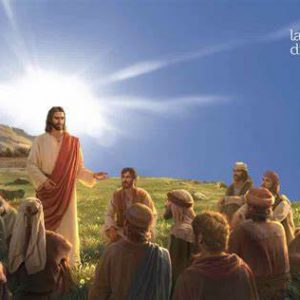Il cielo azzurro di luglio li guardava nelle campagne del “Monaco”, tra limoni e papaveri, avevano i capelli arruffati, la pelle arida e secca, le facce piene di rughe, magri e senza pancia, il cibo non gli bastava mai, il tanfo di sudore e di dignitosa miseria li accompagnava da sempre, erano i contadini “adduati” scesi dalle Madonie. Verso la scurata il curatolo dava il segnale e loro smettevano di lavorare, stanchi, sfiniti, sembrava che volessero addormentarsi sul posto, sulle trazzere impolverate della “Serafina”, vicino al canale della Vorica e di quello dell’acqua della Chiana.
I loro pensieri, umili e semplici, volavano a “lu paisi”, Caltavuturu, Petralia, Bompietro, ai loro parenti, alla Piazza, ai circoli ricreativi, alle domeniche con la banda musicale, al passeggio nel Corso, alle donne “sognate”, ad una vita difficile. Io stavo al di là del canale, dove il canneto mi lasciava uno spazio per guardare quel teatro con quei personaggi nella rituale recita giornaliera del sopravvivere.
Era l’estate del 1963, mio padre mi confinava per mezza giornata, volente o nolente, a stare lì, alla “macchina dell’acqua”, il cui
rumore mi teneva compagnia mentre leggevo Tex e Capitan Miki. Mio padre, guardiano d’acqua d’estate, bracciante per il resto
dell’anno, girava per le campagne come una trottola con un Motoguzzi rosso sgangherato, causa di grandi abilii per i tanti
problemi tipo una volta la candela, una volta i freni, la forcella, l’avviamento, mischinu, lo guardavo e pensavo, appena sarò
grande gli compro uno di quei motori che volano, lucidi e grossi, ma non cavalcò mai più nessun motore, né piccolo né grande,
andò via troppo presto.
I ficarazzoti non lavoravano dentro il “Monaco”, anzi disprezzavano quei poveri Cristi perché si facevano pagare la metà e rompevano la piazza, lavoravano dalla mattina alla sera, non si lamentavano mai, venivano da una fame ancora più nera
della nostra, ma erano onesti e buone persone, più di uno anni dopo prese moglie in paese. Erano ospitati nel casolare accanto alla chiesa di San Francesco, tra mura spoglie e senza luce, si preparavano da mangiare e dormivano su trispiti e tavolacci, su materassi di paglia, con il curatolo, magro e scuru che gli stava sempre addosso. In paese impararono a conoscerli e in piazza se ne parlava spesso, come pure nei bar e nei barbieri, e cominciò a nascere un poco di simpatia per questi picciotti sempre tristi, sempre a lavorare in quel feudo che lasciavano ogni tanto per tornare nei loro paesi prendendo la corriera.
L’antipatia era tutta per il curatolo che stava in giacca e cravatta anche quando il caldo ti squagliava, che faceva lavorare qualche nostro paesano sottopagandolo, magari pensionato o disoccupato, sperando che diventasse confidente. Ma i pochi paesani che ci lavoravano se ne fregavano di lui e quando era possibile si portavano via pure i meloni che erano piantati tutti vicino alla gebbia, proprio di fronte alla mia “postazione”, contrada Ferreri Quattrociocchi, dove mi prendevo il fresco accanto alla cabina dell’Enel, guardavo, osservavo e scrutavo, non mi sfuggiva niente.
Vedevo le guardie campestre, nella loro divisa da finanzieri spogliati con il fucile a tracolla, che nemmeno se c’erano 40 gradi si toglievano la giacca, sempre in coppia, baffetti e cappello, tutti presi dal dovere di acchiappare qualche disgraziato con un pugno di fagiolina in mano o qualche panaro di nespole, ma tutti in paese li guardavano con astìo e frequenti erano le liti o gli inseguimenti con picciotti che andavano per le campagne. Quando loro giravano per il Monaco non si vedeva anima viva,
appena arrivavano all’altezza della Figurella c’era l’assalto ai muluna. In quei pomeriggi assolati u zù Ciccio La Targia, una
brava persona, campò fino ai 90 anni, era siccu siccu ma non si fermava mai.
U zù Ciccio faceva il vaccaro, ma lavorava insieme ai poveri cristi e alla fine della giornata si tagliava l’erba per le sue vacche. Vedevo il suo asino, impaiato al carretto, che si mangiava tutti i papaveri che crescevano dentro il Monaco, questo asino era sveglio e ragliava sempre, fino a quando qualche persona “perbene” decise di rubarglielo e lo zù Ciccio ci restò male assai. Questo fu l’unico asino della terra che grazie ai papaveri si fece viaggi celestiali e divenne figlio dei fiori, insomma fu un’asino che si faceva le canne! Io nei pomeriggi trascorsi a guardare l’immensa distesa dei 4 Ciocchi vedevo quei “viddani”, come li chiamavano in paese, chini a zappare senza quasi mai alzarsi, qualche cantata triste ogni tanto, ma durava poco, il curatolo interveniva e diceva:-“…chi è, c’è festa?…” e ritornava il silenzio.
Appena faceva buio rientravano al casolare, si lavavano alla fontanella, si prendevano un poco di fresco sotto il grande albero
di gelsi prima della cena, una cena frugale, ogni tanto minestrone, insalate di patate, cipolle e pomodori, qualche pezzo di formaggio e del vino che portava il curatolo.
Lui sosteneva che era di quello buono, ma i viddani quando assaggiarono il vino della cantina Monti, capirono la differenza
con quello che portava il curatolo, a loro portava aceto e lui si beveva il vino buono, eh cosa inutile! Quando i meloni furono
maturi, uno di loro, un certo Tanino, piccolino, magro come una sarda, un poco balbuziente, ma buono come il pane, pigliò un
muluni, s’avvicinò alla rete dietro alla gebbia e me lo regalò. – “…mettilo in frigo e te lo mangi…” mi disse tutto guardingo correndo via subito, aveva timore che il curatolo lo vedesse.
Tanino si sposò a Ficarazzi, lavorò ancora nella campagna della moglie e poi lasciò questo mondo alcuni anni fa. Quell’estate la
ricordo come l’estate dei muluna, poiché appena in paese si sparse la voce che i muluna erano “fatti”, in quei pomeriggi dal caldo afoso, quando le cicale cantavano fino a morire, ci fu l’assalto ai muluna!
Saltavano dalla Figurella, dalla Ferrovia, scavalcavano il cunnuttu della Vorica, salivano dallo stradone di via Merlo, si calavano e
acchiappavano uno, due, tre, quattro meloni belli grossi, dalla buccia striata gialla, qualcuno cadeva, il melone si spaccava e il
rosso ti colpiva, lo mangiavi lì, caldo, ti bagnava il viso, il sapore, il profumo ti stordiva. Io stavo in piedi, davanti alla “macchina
dell’acqua”, gurdavo tutto quel viavai e ridevo. Arrivòmio padre, tutto sudato, bruciato dal sole, veniva a chiudere una “mano
d’acqua” e correva per aprirne un’altra, mi guardò mentre ridevo, …”-ma chi cosa sta talìannu,…picchì ridi…non c’è nessuno e tu
ridi…mah…piuttosto sta attento che deve venire Aspanu Greco, digli che io l’aspetto a Ligno Verde, che gli do l’acqua…non lo
dimenticare…talè ancora ride…”.
E tutti arraffavano muluna e correvano. Ci venivano con la Lapa, chi con la 500, chi col carretto, a piedi, in bici, quell’estate tutta
Ficarazzi mangiò muluna…
PS…Dedicato a Tanino di Caltavuturu…
Giuseppe Morreale
Potete approfondire con i seguenti suggerimenti:
Scopri di più da BagheriaInfo.it
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.